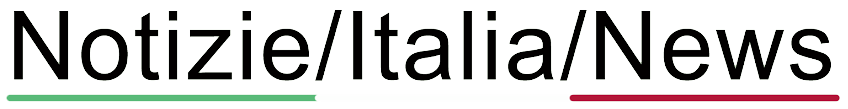Mahmood, uno di noi
Non mi aspettavo di dover
commentare il festival di Sanremo. In tanti anni non l’ho mai seguito. Assicuro
non per essere snob, semplicemente non mi sono mai piaciute buona parte delle canzoni
rappresentate. Anche l’edizione di quest’anno l’ho seguita superficialmente, tra
uno zapping compulsivo e l’altro, soprattutto nel corso della pubblicità.
Eppure mi piace Claudio Baglioni, come tanti mi sono innamorato con le sue
canzoni. E ho simpatia anche per Claudio Bisio e Virginia Raffaele. Mi spingono
a scrivere alcune considerazioni sul Festival appena terminato le polemiche che
hanno accolto la vittoria di Mahmood, giovane italo-egiziano. Diligentemente mi
sono documentato e ho scoperto che si tratta di un ragazzo che si definisce
italiano e si chiama Alessandro, ma ha scelto come nome d’arte Mahmood. Nato e
vissuto in Italia, ha un padre egiziano e musulmano; ama definire la sua musica
marocco pop, genere che francamente
ignoro (e onestamente neanche desidero approfondire) e che qualcuno non ha
esitato a definire un apparente ossimoro. Ossimoro che, tuttavia, evoca della musica
intesa come fenomeno insieme globale e localmente rielaborato.
commentare il festival di Sanremo. In tanti anni non l’ho mai seguito. Assicuro
non per essere snob, semplicemente non mi sono mai piaciute buona parte delle canzoni
rappresentate. Anche l’edizione di quest’anno l’ho seguita superficialmente, tra
uno zapping compulsivo e l’altro, soprattutto nel corso della pubblicità.
Eppure mi piace Claudio Baglioni, come tanti mi sono innamorato con le sue
canzoni. E ho simpatia anche per Claudio Bisio e Virginia Raffaele. Mi spingono
a scrivere alcune considerazioni sul Festival appena terminato le polemiche che
hanno accolto la vittoria di Mahmood, giovane italo-egiziano. Diligentemente mi
sono documentato e ho scoperto che si tratta di un ragazzo che si definisce
italiano e si chiama Alessandro, ma ha scelto come nome d’arte Mahmood. Nato e
vissuto in Italia, ha un padre egiziano e musulmano; ama definire la sua musica
marocco pop, genere che francamente
ignoro (e onestamente neanche desidero approfondire) e che qualcuno non ha
esitato a definire un apparente ossimoro. Ossimoro che, tuttavia, evoca della musica
intesa come fenomeno insieme globale e localmente rielaborato.
Ho ascoltato la sua canzone, ma
non è di essa che voglio parlare. Vivo a Roma e conosco tanti cittadini di
origine egiziana, compreso il rapper Amir Issaa, madre italiana e padre
egiziano, cresciuto a Tor Pignattara. Una sera – dopo essersi esibito al
Colosseo nel corso di una edizione della Giornata Internazionale Città per la
Vita Città contro la Pena di Morte organizzata dalla Comunità di Sant’Egidio –
mi disse «io qua ci sono nato, non devo
integrarmi. Non sono un immigrato e non sono un terrorista, sono un italiano. Non
sono un rifugiato e mi piace la pasta e la pizza».
non è di essa che voglio parlare. Vivo a Roma e conosco tanti cittadini di
origine egiziana, compreso il rapper Amir Issaa, madre italiana e padre
egiziano, cresciuto a Tor Pignattara. Una sera – dopo essersi esibito al
Colosseo nel corso di una edizione della Giornata Internazionale Città per la
Vita Città contro la Pena di Morte organizzata dalla Comunità di Sant’Egidio –
mi disse «io qua ci sono nato, non devo
integrarmi. Non sono un immigrato e non sono un terrorista, sono un italiano. Non
sono un rifugiato e mi piace la pasta e la pizza».
Mahmood e il rapper Amir Issaa sono
l’espressione di un’Italia neanche tanto nuova che si è formata in questi ultimi
decenni. Un’Italia in cui crescono – ci segnala il sociologo Ambrosini – tra i
nostri figli i figli di coppie miste (quasi 19mila matrimoni misti nel 2016,
9,3% del totale), nonché i ragazzi e le ragazze di origine immigrata (quasi 1,3
milioni), ma socializzati, scolarizzati (826.000) e sempre più spesso anche
nati nel nostro Paese (quasi 68.000 nel 2017). Si tratta di un’evoluzione
demografica che non sconvolge l’identità culturale italiana. Tutt’altro, la
rende più composita, variegata e inevitabilmente complessa. In altri termini, abbiamo
e avremo sempre più italiani di pelle scura, con gli occhi a mandorla, con il
velo o con il turbante, con cognomi irti di consonanti e difficili da pronunciare,
di nome Mahmoud, Svetlana, Mariam, Adam, Gabriel, Andrei, Kevin, Daniel, Carlos,
e tanti altri. Non è un cambiamento indolore. Ad alcuni di loro, come
insegnante di storia, insegno la storia moderna e contemporanea con prevalenti
riferimenti alle vicende del nostro paese. Anch’essi fruiscono degli sviluppi
della nostra lingua che nel corso del Novecento si è imposta, soprattutto
grazie allo sviluppo della diffusione dell’istruzione, della radio, poi della
tv. Non solo la Nazionale di calcio sviluppa un senso di appartenenza e di
identificazione nazionale.
l’espressione di un’Italia neanche tanto nuova che si è formata in questi ultimi
decenni. Un’Italia in cui crescono – ci segnala il sociologo Ambrosini – tra i
nostri figli i figli di coppie miste (quasi 19mila matrimoni misti nel 2016,
9,3% del totale), nonché i ragazzi e le ragazze di origine immigrata (quasi 1,3
milioni), ma socializzati, scolarizzati (826.000) e sempre più spesso anche
nati nel nostro Paese (quasi 68.000 nel 2017). Si tratta di un’evoluzione
demografica che non sconvolge l’identità culturale italiana. Tutt’altro, la
rende più composita, variegata e inevitabilmente complessa. In altri termini, abbiamo
e avremo sempre più italiani di pelle scura, con gli occhi a mandorla, con il
velo o con il turbante, con cognomi irti di consonanti e difficili da pronunciare,
di nome Mahmoud, Svetlana, Mariam, Adam, Gabriel, Andrei, Kevin, Daniel, Carlos,
e tanti altri. Non è un cambiamento indolore. Ad alcuni di loro, come
insegnante di storia, insegno la storia moderna e contemporanea con prevalenti
riferimenti alle vicende del nostro paese. Anch’essi fruiscono degli sviluppi
della nostra lingua che nel corso del Novecento si è imposta, soprattutto
grazie allo sviluppo della diffusione dell’istruzione, della radio, poi della
tv. Non solo la Nazionale di calcio sviluppa un senso di appartenenza e di
identificazione nazionale.
L’anno scorso, di questi tempi proprio a pochi
giorni dell’elezioni politiche del 2018, avevamo già sperimentato la cocente e deludente
fine della proposta di riforma della legge sulla cittadinanza. Essa non è
neppure nell’agenda del nuovo governo, non rientra nel cosiddetto contratto tra
le forze politiche al potere e nei messaggi che lanciano agli elettori. Nessuno
vuole porre fine al senso di appartenenza e di identificazione nazionale,
caratterizzato da un patrimonio di legami e di codici culturali tutt’altro che
obsoleti. Nelle Scuole di lingua e cultura della Comunità di Sant’Egidio si
impara, in primo luogo, l’italiano. Si impara quindi a conoscere la cultura
italiana nei suoi diversi aspetti, si affrontano i grandi temi del razzismo,
della pace e della guerra, si parla dei fondamenti costituzionali della
Repubblica, si apprende la storia contemporanea e si insiste sulla necessità di
comprendere i diversi mondi di provenienza degli studenti. Ma, soprattutto, le
scuole d’italiano sono luoghi dove si costruisce la convivenza, abituandosi a
rapportarsi con persone diverse. Sono un vero laboratorio della civiltà del
convivere, un modello concreto, una cosiddetta buona pratica, per costruire
l’integrazione e la convivenza. Una sfida per il futuro, un’opportunità
d’inclusione e di allargamento, anziché di ripiegamento e di chiusura, con nuove
energie e nuovi stimoli. Del resto altre soluzioni sono complicate: potremmo
mai mandare via questi giovani, che di fatto non hanno più un’altra patria a
cui tornare? Oppure potremmo sbiancarli, obbligarli a rinunciare alle loro origini
e alla loro storia familiare?
giorni dell’elezioni politiche del 2018, avevamo già sperimentato la cocente e deludente
fine della proposta di riforma della legge sulla cittadinanza. Essa non è
neppure nell’agenda del nuovo governo, non rientra nel cosiddetto contratto tra
le forze politiche al potere e nei messaggi che lanciano agli elettori. Nessuno
vuole porre fine al senso di appartenenza e di identificazione nazionale,
caratterizzato da un patrimonio di legami e di codici culturali tutt’altro che
obsoleti. Nelle Scuole di lingua e cultura della Comunità di Sant’Egidio si
impara, in primo luogo, l’italiano. Si impara quindi a conoscere la cultura
italiana nei suoi diversi aspetti, si affrontano i grandi temi del razzismo,
della pace e della guerra, si parla dei fondamenti costituzionali della
Repubblica, si apprende la storia contemporanea e si insiste sulla necessità di
comprendere i diversi mondi di provenienza degli studenti. Ma, soprattutto, le
scuole d’italiano sono luoghi dove si costruisce la convivenza, abituandosi a
rapportarsi con persone diverse. Sono un vero laboratorio della civiltà del
convivere, un modello concreto, una cosiddetta buona pratica, per costruire
l’integrazione e la convivenza. Una sfida per il futuro, un’opportunità
d’inclusione e di allargamento, anziché di ripiegamento e di chiusura, con nuove
energie e nuovi stimoli. Del resto altre soluzioni sono complicate: potremmo
mai mandare via questi giovani, che di fatto non hanno più un’altra patria a
cui tornare? Oppure potremmo sbiancarli, obbligarli a rinunciare alle loro origini
e alla loro storia familiare?
Dimenticavo di dire cosa pensavo
delle polemiche dalle quali ero partito: certamente – forse involontariamente –
hanno sollevato questioni importanti, ma hanno assunto tratti
penosi.
delle polemiche dalle quali ero partito: certamente – forse involontariamente –
hanno sollevato questioni importanti, ma hanno assunto tratti
penosi.
Antonio Salvati
Latest posts by Antonio Salvati (see all)
- La Chiesa, Papa Francesco e le social network communities - 11 Luglio 2019
- Mussolini ha fatto anche cose buone? - 9 Luglio 2019
- Italiani sempre meno. Il Belpaese senza gli italiani - 4 Luglio 2019